Ancora lingue antiche… o siete stanchi?
Mag 22
Lo so, due settimane fa i manoscritti in lingua sarda, oggi quelli in lingua volgare italiana: potreste essere stufi di certi argomenti…
Ma mi pareva di aver preso un bell’avvio, non potevo lasciarlo così. E poi mi sono tornate in mente le letture di due tra i più grandi studiosi italiani, cui non sarò mai abbastanza debitrice, Armando Petrucci e Attilio Bartoli Langeli.
La loro intelligenza e superiorità – lo sguardo ampio, l’intuizione geniale, la capacità di approfondirla e poi trasmetterla – nel saper indagare il più banale dei documenti ha illuminato la strada a moltissimi studenti, studiosi e curiosi. Alla fine del post troverete i titoli di un paio dei loro libri, e intanto vi racconto uno tra i tanti argomenti che ho imparato seguendo le loro ricerche: la scrittura della lingua volgare italiana.
Che sia detta ‘volgare’ perché parlata (e scritta) dal volgo, dal popolo, ormai è noto. Quello che non tutti sanno è che ci sono molti modi per parlare e per scrivere il volgare (come accade ancora oggi) e non solo perché tante sono le regioni e le tradizioni linguistiche, ma anche perché diverse erano le conoscenze e le abitudini, gli usi e le necessità di coloro che dovevano applicarsi in questa attività, così impegnativa.
Siamo tra il XIII e il XIV secolo. La questione era complessa: si trattava di scrivere con un alfabeto che fino ad allora era stato usato per scrivere in un’altra lingua, il latino, senza punti di riferimento e senza esempi. In poche parole, bisognava scrivere ascoltandosi parlare, e leggere facendo l’operazione inversa: e non è detto che il risultato portasse alla medesima conclusione…
Di certo l’uso del volgare permetteva a molte più persone di avvicinarsi al mondo scritto. Sono notevoli le testimonianze di coloro che ne sentirono un tale bisogno da avventurarsi ugualmente in una realtà piena di insidie. Eppure in tanti vollero imparare.
Alcuni si specializzarono in poche frasi o anche nel solo nome, da mettere in calce a carte e moduli. Altri scrissero senza alcun criterio di ortografia e di sintassi, evitando accuratamente apostrofi e accenti, per non parlare della punteggiatura, e con terribili difficoltà nel decidere la fine di una parola e l’inizio di un’altra, ciò che mentre parliamo non necessariamente avvertiamo.
«Io ti priecho chetutorni tosto ionono achora fachto il filgiolo» scrisse Maddalena Strozzi al marito Neri di Donato Acciaiuoli, esule da Firenze, informandolo della sua gravidanza e pregandolo di tornare in fretta.
Giovanni Ghezzo, un contadino toscano che non era mai stato a scuola, volle scrivere per comunicare con il suo principale. La sua lettera così s’avvia: «avanni. Gheço uisi rachomada. Ebib una letara laqualemadaste iosoe» (a Vanni. Ghezzo vi si raccomanda. Ebbi una lettera la quale mandaste, io so e…).
C’era chi sapeva leggere e scrivere, chi sapeva solo leggere o solo scrivere, chi era in grado di scrivere solo alcune parole o frasi, o aveva memorizzato le lettere del proprio nome per firmare.
Le conoscenze erano perlopiù funzionali all’attività lavorativa. Di certo la maggior parte dei ‘semicolti’, così si definiscono coloro che non avevano avuto una sufficiente istruzione, sapevano scrivere meglio di quanto sapessero leggere, e soprattutto sapevano fare di conto.
L’insegnamento della scrittura si basava soprattutto sull’imitazione e quindi si può quasi dire che chiunque avesse un minimo di conoscenza potesse trasmetterne le basi. Giovanni Antonio da Faie, toscano della Lunigiana, si ingegnava a imparare a scrivere facendosi mostrare le lettere dagli studenti che lavoravano nella sua bottega «tanto che imparò l’abe e cognose le letere molto bene». L’abe in effetti sarebbe l’abc (e notate che parla di sé in terza persona).
Mai come tra il XIV e il XV secolo si trovavano così tante tipologie di scritture diverse: c’erano scritture per i libri e quelle per i documenti; quelle per libri in latino e quelle per il volgare; scritture per questioni personali e per note pubbliche.
Di certo la consapevolezza dell’importanza di saper scrivere era piuttosto forte perché come scrisse Michelangelo da Volterra nel 1450, chi non sa scrivere e leggere «è in questo mondo come un’immagine di marmo, et può dire di non ci essere».
E se Michelangelo è un uomo colto e forse più consapevole, ci sono testimonianze anche di altro genere che ci permettono di cogliere tale consapevolezza: all’inizio del Seicento, nel Rione Campitelli di Roma, un quartiere popolare, i genitori scrivono al papa Paolo V perché conceda loro di avere un maestro nel quartiere: «Francesco Santini et in Fra scriti espongono con ogni venerenza alla S.ta sua, come sono quatro anni in circa, che nel Rione di Campitelli non c’è Maestro di scola, et molte povere vedove, et alte miserabile persone non hanno dove mandare i lor figloli, se nò nelle Scuole pie in San pantaleo con grandisima scomodità et di lungo viago, e che sono maluestiti…»
Possiamo vivere senza saper leggere e scrivere, perfino ora, in questo mondo tutto scritto, ma non potremo partecipare, conoscere (e dunque crescere), comunicare davvero, fino in fondo, quello che desideriamo e quello che siamo. Saremmo come delle statue di marmo e potremmo dire di non esistere.
**Per cominciare a conoscere Bartoli e Petrucci, suggerirei questi due volumi, all’interno dei quali troverete moltissimi riferimenti bibliografici:
Attilio Bartoli Langeli, La scrittura dell’italiano, Bologna, Il Mulino, 2000 (L’identità italiana, 19)
Armando Petrucci, Prima lezione di paleografia, Bari-Roma, Laterza, 2007
- Ghezzo
- Cecilia Merisi
- Maddalena Strozzi








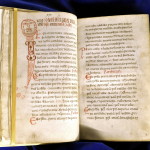


 Come e perché si è costituita la biblioteca delle Balate?
Come e perché si è costituita la biblioteca delle Balate? Mi chiamo Adriana Paolini. Le persone che mi stanno più vicine mi chiamano mamma, Adri, papposilla, alcuni mi chiamano, ironicamente, ma affettuosamente, Paolini, altri Madama Codicò.
Sono nata al mare, a Pescara, e vivo in montagna, a Trento.
Mi chiamo Adriana Paolini. Le persone che mi stanno più vicine mi chiamano mamma, Adri, papposilla, alcuni mi chiamano, ironicamente, ma affettuosamente, Paolini, altri Madama Codicò.
Sono nata al mare, a Pescara, e vivo in montagna, a Trento.


Ultimi commenti